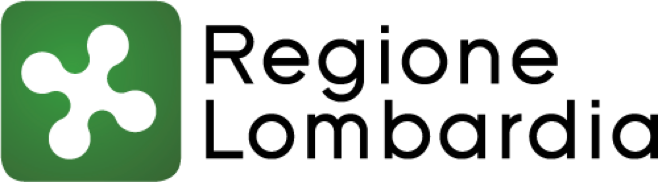Neve e ghiacciai
Si riporta l'ultima analisi disponibile.
La stagione invernale 2024-2025 è stata caratterizzata da innevamento ridotto rispetto all’inverno 2023-2024, risultando peggiore sia in termini di accumulo nivale, sia di volume di acqua di fusione a lento rilascio disponibile nel periodo tardo-primaverile ed estivo. L’avvio è stato piuttosto tardivo alle quote medie, mentre in alta montagna non sono mancate alcune fasi di precipitazioni nevose significative che hanno contribuito a un discreto accumulo iniziale. I mesi centrali dell’inverno (dicembre e parte di gennaio) sono stati caratterizzati da condizioni più miti e da un generale innalzamento della quota neve (indice del cambiamento climatico in atto), fattori che hanno limitato la persistenza del manto nevoso soprattutto sotto i 1800–2000 m. La parte finale della stagione e l’inizio della primavera hanno invece beneficiato di nuovi apporti nevosi e precipitazioni più frequenti, con conseguente recupero parziale dell’innevamento.
Dal confronto delle medie annuali per le rispettive stazioni di riferimento con i dati raccolti durante la suddetta stagione invernale, si può notare come il volume di neve fresca cumulata sia al di sotto delle medie storiche. La riduzione risulta particolarmente evidente nelle Orobie (es. Carona, Valgerola e Aprica) e Retiche Occidentali (es. Madesimo), dove lo scarto negativo rispetto alle serie storiche appare marcato (Immagine).
L’innevamento di questa stagione registra un deficit rispetto alla media degli ultimi 34 anni, specialmente nelle fasce altimetriche inferiori ai 2000 m. Le nevicate tardi-stagionali hanno tuttavia contribuito a un miglioramento finale della copertura nevosa, utile per il mantenimento delle risorse idriche primaverili.
Di seguito vengono analizzati gli aspetti e gli eventi meteorologici principali che hanno caratterizzato la stagione invernale 2024-2025 nei diversi settori delle montagne lombarde.
Autunno (ottobre–novembre)
L’inizio di stagione si è distinto per la scarsità di precipitazioni solide e per un deposito nevoso generalmente modesto, anche sopra i 2000 m, dove non sono stati superati i 40 cm di neve al suolo presso Passo Marinelli (3032 m s.l.m.).
Dai primi di novembre le temperature hanno subito un deciso calo, con una prima nevicata significativa nella seconda metà del mese che ha prodotto fino a 30 cm di neve fresca in quota.
Inverno (dicembre-febbraio)
Le perturbazioni di dicembre sono risultate frequenti ma di debole intensità, concentrandosi sui settori alpini oltre i 1800 m, con spessori medi al suolo compresi fra 20 e 60 cm.
Nel mese di gennaio si sono verificati due episodi nevosi rilevanti (6 e 29 gennaio), con accumuli di neve fresca rispettivamente di 40 cm e 60 cm.
Complessivamente, tra novembre e gennaio gli apporti sono stati di moderata entità, ma nettamente inferiori alle medie stagionali. Il manto nevoso è stato molto eterogeneo per tutto l’inizio della stagione invernale a causa anche del vento forte in quota, con alternanza di versanti erosi e aree d’accumulo. Da un punto di vista nivologico, tali condizioni hanno favorito la formazione di lastroni da vento poggianti su strati deboli di cristalli sgranati, aumentando il pericolo di valanghe a lastroni.
Il mese di febbraio si presenta piuttosto stabile dal punto di vista meteorologico, con temperature quasi sempre inferiori agli 0°C oltre i 2000 m e un solo evento precipitativo con accumuli tra i 20 e i 40 cm, più significativi su Orobie e Retiche occidentali. Nel complesso contesto favorevole alla preservazione del manto nevoso.
Primavera (marzo–maggio)
Marzo e aprile hanno mostrato un’attività precipitativa contenuta ma con un episodio di rilievo a metà marzo, che ha apportato 50–60 cm di neve fresca su Retiche orientali e Adamello e 80–100 cm su Orobie, Retiche occidentali e Prealpi bresciane.
Al di sotto dei 2300 m la neve è risultata umida e soggetta a fusione progressiva, mentre alle quote superiori gli spessori si sono mantenuti pressoché costanti (100–150 cm) fino ad aprile, grazie a nuove nevicate d’alta quota con accumuli fino a 20 cm sopra i 2400 m.
Le temperature registrate nel periodo hanno oscillato fra massime intorno ai 10 °C e minime fino a –15 °C, permettendo cicli di fusione e rigelo che hanno migliorato la stabilità complessiva del manto. Con l’arrivo di maggio le temperature subiscono un aumento progressivo, decretando così il termine della stagione di accumulo nevoso, nonostante un evento del 22 maggio con accumuli maggiori di 30 cm al di sopra dei 2400 m.
Sulle Prealpi lombarde gli eventi nevosi sono risultati poco frequenti e di modesta entità. Gli accumuli al suolo non hanno superato i 20 cm tra i 1000 e 1200 m e i 30 cm alle quote più elevate, fino a circa 1800 m.
Oltre i 1300 m, nelle aree delle Prealpi bresciane e lariane, si evidenziano tre episodi principali che hanno contribuito in modo significativo alla limitata copertura nevosa stagionale, rispettivamente a metà dicembre, tra metà e fine gennaio e a metà febbraio. Tali eventi, pur caratterizzati da quantitativi modesti, hanno consentito il mantenimento di un sottile strato di neve al suolo in alcuni settori, grazie a un andamento termico più favorevole nel periodo invernale centrale.
Nel settore bergamasco e varesino, invece, gli apporti nevosi sono stati ancora più ridotti: alle quote inferiori ai 1100 m i volumi di neve sono risultati minimi, in alcuni casi pressoché assenti.
Dall’inizio di maggio si osserva un generale esaurimento dell’innevamento, con territorio privo di copertura nevosa anche alle quote superiori ai 1800 m.
La stima del contenuto idrico della neve (SWE) a scala regionale, consente di valutare la quantità totale di equivalente in acqua immagazzinata nella neve e la sua distribuzione spaziale. Tale parametro riveste notevole importanza nel bilancio idrologico, in quanto rappresenta una riserva idrica che ha capacità di rilascio graduale ed è al tempo stesso un fattore da monitorare nella catena di controllo e di allertamento idrogeologico.
Il calcolo del SWE si basa sulla valutazione dell'estensione della copertura nevosa e sulla misurazione dell'altezza e della densità del manto nevoso.
I campionamenti sono stati svolti alle quote comprese tra i 2.877 metri sulla Vedretta di Savoretta ed i 3.645 del Ghiacciaio di Fellaria Orientale. Questi completano ed integrano i dati raccolti in continuo attraverso la rete capillare di stazioni nivometeorologiche automatiche presenti sul territorio montano lombardo collocate a quote inferiori.
Sono stati eseguiti complessivamente 51 carotaggi e decine di misure dell’altezza del manto nivale su:
- ghiacciai del Vioz e Dosegù nel Sottogruppo Cevedale-San Matteo;
- ghiacciaio dei Vitelli nel Sottogruppo Ortles-Cristallo;
- ghiacciai dell’Adamello e del Pisgana nel Gruppo dell’Adamello;
- ghiacciai di Fellaria Orientale e dello Scalino nel Gruppo del Bernina.
- ghiacciai di Alpe Sud e di Savoretta nel Gruppo Sobretta-Gavia.
Dai dati complessivamente raccolti emerge che l’ultima stagione è stata caratterizzata, nella prima parte dell’inverno, da un innevamento al di sotto della media su tutte le montagne lombarde, seguito da un assestamento su valori in linea con la media del periodo 2006-2020.
Nell’immagine 3 viene riportato l'equivalente in acqua della neve (SWE) calcolato a partire dai dati raccolti, espresso in kg/m² (ovvero considerato come il peso dell'acqua di disgelo per metro quadrato che risulterebbe se il manto nevoso si fondesse del tutto).
Confrontando in particolare i dati raccolti dalla campagna SWE sui principali apparati glaciali, condotta dal Centro Regionale Neve e Valanghe di Arpa Lombardia a partire dal 2016, si può osservare come lo SWE medio della stagione 2024-2025 risulti notevolmente inferiore alla stagione precedente, con un decremento medio della risorsa idrica che si aggira intorno al -48%.
Sono stati riscontrati quantitativi di neve notevolmente inferiori rispetto alla stagione 2023-2024. Gli spessori del manto variano tra i 1,3 e 4,9 m sui diversi ghiacciai, con minimo nelle quote più basse e una densità media di 516 kg/m3. I valori più elevati di SWE sono stati misurati nella zona dell’alta Valmalenco sull’ apparato glaciale del Fellaria Orientale (20 m di neve cumulata) e dello Scalino (18 m di neve cumulata). Valori compresi tra 10 e 15 m di neve cumulata sui ghiacciai dell’Adamello, del Dosegù, del Pisgana, del Vioz, dei Vitelli, di Savoretta e di Sobretta.
Durante la campagna SWE 2025 sono stati svolti campionamenti del manto nevoso volti a misurare il contenuto di microplastiche sui principali bacini di accumulo regionale.
In particolare, i campionamenti hanno riguardato i ghiacciai di Dosegù – Alta Valtellina e Fellaria – Alta Valmalenco.
I risultati delle analisi hanno mostrato una presenza diffusa di microplastiche in entrambi i siti, con concentrazioni significativamente più elevate nel campione del Ghiacciaio Dosegù (circa 160.000 particelle per campione) rispetto a quello del Ghiacciaio Fellaria (circa 26.000 particelle). In entrambi i casi le particelle risultano prevalentemente di dimensioni inferiori a 100 µm, indicatrici di deposizione atmosferica a lunga distanza.
La composizione differisce parzialmente tra i due ghiacciai: al Fellaria prevalgono PET e poliammide (PA) di origine sintetica, mentre al Dosegù si riscontra una predominanza di poliammidi naturali e cellulosa, con un contributo più marcato di gomma e PTFE.
Queste differenze suggeriscono una maggiore accumulazione di particolato misto, naturale e antropico, sul Ghiacciaio Dosegù, verosimilmente legata alla sua posizione orografica più esposta ai trasporti atmosferici meridionali.
I ghiacciai rispondono in modo diretto e rapido alle dinamiche di cambiamento climatico (variazioni di temperatura e regimi pluviometrici), modificando le proprie caratteristiche morfologiche e la loro dinamica con una riduzione della massa glaciale, un progressivo arretramento delle fronti, un aumento delle zone crepacciate, la formazione di depressioni e laghi sulla superficie, e un incremento dell’instabilità dei seracchi pensili. Questa grande sensibilità alle variazioni climatiche rende i ghiacciai preziosi indicatori che consentono di quantificare l’intensità con cui sta agendo il riscaldamento globale. Il Centro Regionale Neve e Valanghe di ARPA Lombardia monitora diversi ghiacciai sull’arco alpino lombardo, sia tramite rilievi invernali finalizzati a quantificare l’entità degli accumuli nivali (SWE – Snow Water Equivalent), sia nel periodo estivo-autunnale per quantificarne la perdita di massa attraverso diverse metodologie di rilievo:
- lettura delle paline ablatometriche (aste di legno infisse nel ghiaccio per 10 m e solidali con esso, che, a seguito della sua progressiva fusione superficiale, emergono permettendo di misurarne puntualmente la perdita di spessore);
- rilievi fotografici sul campo (rilievi geodetici tramite GNSS e aerofotogrammetria, misure georadar)
- elaborazione di immagini satellitari.
A partire dall’estate 2025, il Centro Neve e Valanghe di ARPA Lombardia ha affiancato alla lettura puntuale delle paline un ablatometro digitale, strumento utile per ottenere una lettura continua (seppur sempre puntuale) del tasso di fusione, integrata con misure di temperatura, umidità e pressione grazie a sensori posizionati direttamente sull’ablatometro. Dai dati raccolti durante la stagione si può affermare che il 2025 è stato un anno con valori di riduzione della massa glaciale simili al 2024, con un trend negativo persistente, sebbene lontano dai valori estremi del 2022, anno peggiore della serie. Dopo una stagione invernale e primaverile caratterizzata da scarse precipitazioni, è seguita una stagione estiva con temperature in quota non eccessivamente elevate nel mese di luglio, permettendo ai ghiacciai alle quote più elevate di preservare buona parte della copertura nevosa invernale. Nel settore Retico sono state misurate riduzioni di spessore medie intorno ai 2 metri a 3000 m di quota, con variazioni frontali negative che evidenziano il trend in atto, con conseguente contrazione e arretramento delle lingue glaciali, ormai sempre più assottigliate e arroccate. Tra i ghiacciai monitorati da ARPA Lombardia sull’arco alpino lombardo ci sono il ghiacciaio di Alpe Sud sul massiccio del Monte Sobretta, e il ghiacciaio del Dosegù nell’alta valle del Gavia (Immagine), entrambi situati nel comune di Valfurva (SO). Pur essendo diversi per dimensioni, rappresentano due aree di studio significative.
Il ghiacciaio di Alpe Sud, monitorato costantemente da ARPA Lombardia dal 1997, si estende tra i 3176 m e i 3217 m di quota. Su di esso rimane una sola palina ablatometrica a causa della sua ridotta estensione (inferiore ai 10.000 m²).
I parametri rilevati al termine della stagione estiva, utilizzati per la valutazione del bilancio glaciologico, hanno evidenziato la seguente situazione:
- QMF (quota minima fronte): 3176 m s.l.m.
- ELA (Equilibruim Line Altitude – altitudine media in cui il bilancio di massa del ghiacciaio è zero). L’ELA separa la parte superiore del ghiacciaio (zona di accumulo) con la parte inferiore (zona di ablazione): assente
- AAR (Accumulation Area Ratio – percentuale di ghiacciaio coperta da neve residua a fine estate indicata con valori da 0 (neve assente) a 1 (innevamento sul 100% della superficie): 0
- Variazione di massa annuale spazializzata: circa -185 cm di spessore (dato derivante dalla lettura della palina ablatometrica)
- IBM (indice di bilancio di massa annuale – derivato dalla tabella per la definizione convenzionale dell’indice di Bilancio di Massa): decremento forte
|
DEFINIZIONE CONVENZIONALE DELL’INDICE DI BILANCIO DI MASSA |
|||
|
incremento forte |
IF |
Neve vecchia sull’intero corpo glaciale e anche sul terreno circostante |
AAR >1 |
|
incremento moderato |
IM |
Neve vecchia estesa all’intero corpo glaciale |
AAR ~1 |
|
incremento lieve |
IL |
Neve vecchia su buona parte del ghiacciaio: > 60% |
AAR >0.6 |
|
stazionario |
S |
Nessuna variazione morfologica significativa rispetto al controllo precedente. Neve vecchia abbondante su almeno il 50-60 % della superficie |
AAR =0.5-0.6 |
|
decremento lieve |
DL |
Neve vecchia scarsa: < 50-60 % della superficie |
AAR <0.5-0.6 |
|
decremento moderato |
DM |
Neve vecchia molto scarsa (< 20%) o assente, riduzione di spessore e superficie |
AAR <0.2 |
|
decremento forte |
DF |
Neve vecchia assente, marcata riduzione di spessore e superficie |
AAR 0 |
Per monitorare ulteriormente la sua evoluzione, nel 2022 è stata installata una stazione webcam, alla quale è stata aggiunta nella primavera 2025 una stazione meteorologica per la caratterizzazione micrometeorologica del ghiacciaio. Grazie ai dati raccolti, è stato possibile valutare l’andamento delle temperature estive, che hanno raggiunto massimi stagionali di 14,1 °C il 9 agosto 2025 con una media estiva (luglio - settembre 2025) di 3,9°C. Rimangono pochi metri di spessore di ghiaccio sull’Alpe Sud, l’estinzione è certa e si verificherà nell’arco di poche estati. Tali dati, insieme alle analisi condotte direttamente sul campo, sono stati ottenuti grazie all’elaborazione delle immagini satellitari della costellazione europea Sentinel, che offre importanti vantaggi per gli studi glaciologici. Rispetto alla stagione precedente, si è osservato che alle quote maggiori (sopra i 3200 m circa) le temperature estive, non significativamente elevate, non hanno determinato la completa fusione della copertura nevosa invernale (che sul ghiacciaio in analisi si è conservata per circa il 57% rispetto alla superficie totale), mantenendo così il bilancio glaciologico a livello stazionario. Per i ghiacciai a quote inferiori, come l’Alpe Sud, il bilancio di massa è risultato in forte decremento. Per non interrompere la caratterizzazione glaciologica a scala di bacino, il Centro Regionale Neve e Valanghe sta valutando altri candidati, tra cui il ghiacciaio del Dosegù, nel comune di Valfurva (SO), nell’alta valle del Gavia. Nell’estate 2025, sul ghiacciaio è stata installata una rete di misura composta da:
- un ablatometro digitale per acquisire dati continui, seppur puntuali, relativi al tasso di fusione, oltre a misure di temperatura, umidità e pressione;
- paline ablatometriche infisse nel ghiaccio per il controllo manuale della fusione e la taratura dello strumento digitale sopracitato.
Il ghiacciaio si estende tra 2959 m e 3545 mdi quota e presenta una superficie di circa 1,54 km². Come per l’Alpe Sud, sono stati analizzati i parametri glaciologici che hanno evidenziato la seguente situazione:
- QMF: 2959 m s.l.m.
- ELA: compresa tra 3250 e 3350 m di quota
- AAR: 0,57
- Variazione di massa annuale spazializzata: circa -145 cm di spessore (dato proveniente dalla lettura delle paline ablatometriche e dall’ablatometro digitale)
- IBM annuale: bilancio stazionario
Tali dati, insieme alle analisi condotte direttamente sul campo, sono stati ottenuti grazie all’elaborazione delle immagini satellitari della costellazione europea Sentinel, che offre importanti vantaggi per gli studi glaciologici. Rispetto alla stagione precedente, si è osservato che alle quote maggiori (sopra i 3200 m circa) le temperature estive, non significativamente elevate, non hanno determinato la completa fusione della copertura nevosa invernale (che sul ghiacciaio in analisi si è conservata per circa il 57% rispetto alla superficie totale), mantenendo così il bilancio glaciologico a livello stazionario. Per i ghiacciai a quote inferiori, come l’Alpe Sud, il bilancio di massa è risultato in forte decremento.
La stagione invernale 2024-2025, se si considerano tutti i settori, è stata caratterizzata da una criticità mediamente moderata (grado di pericolo 2 nel 40% dei bollettini emessi, su una scala che va da 1 debole a 5 molto forte) (Immagine)
Sui settori Retici, Adamello e Orobie il grado di pericolo maggiormente utilizzato (con una percentuale pari o superiore al 50% dei bollettini) è stato il 2 moderato. A seguire, il grado 3 marcato, con percentuali comprese tra il 35% e il 39%.
Anche per quanto riguarda le Prealpi Lariane, il grado di pericolo più frequente è stato il 2 moderato (48%), seguito però dal grado 1 debole (43%).
Sulle Prealpi Bresciane e Bergamasche il più ricorrente è stato invece il grado 1 debole (rispettivamente 53% e 70%), seguito dal 2 moderato.
Alle quote delle Prealpi Varesine e dell’Appennino Pavese, lunghi periodi dell’inverno sono stati caratterizzati da assenza di neve: rispettivamente il 45% ed il 59% dei bollettini emessi riportavano l’icona “no snow”.
Il grado 4 forte è stato utilizzato 2 volte su 136 bollettini emessi, in ciascuno dei settori alpini. Nei settori prealpini e appenninici non è mai stato utilizzato.
Rispetto alla passata stagione, quella del 2024-2025 ha mostrato una criticità sensibilmente inferiore, con una minore incidenza di giorni classificati con grado di pericolo 3 marcato e 4 forte, in tutti i settori.
La stagione invernale 2023/2024 è stata migliore rispetto all’inverno 2022-2023. La parte iniziale della stagione è stata caratterizzata da abbondanti precipitazioni su tutti i settori lombardi che ha consentito un buon innevamento. Questo periodo si è seguito da un trend siccitoso lungo i mesi invernali (dicembre, gennaio e febbraio) successivamente variato da una primavera ricca di precipitazioni e temperature miti garantendo un generale recupero e mantenimento dell’innevamento medio.
Dal confronto delle medie annuali per le rispettive stazioni di riferimento con i dati raccolti durante la suddetta stagione invernale, si può notare come il volume di neve fresca cumulata tendenzialmente sia al di sopra delle medie. Pertanto, si conferma che le precipitazioni nevose sono state maggiori sulle montagne appartenenti ai settori delle Retiche Centrali e dell’Adamello (vedi immagine).
L’innevamento di questa stagione registra una eccedenza rispetto alla media degli ultimi 24 anni, grazie alle abbondanti precipitazioni e temperature più miti arrivate principalmente tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.
Di seguito vengono analizzati gli aspetti e gli eventi meteorologici principali che hanno caratterizzato la stagione invernale 2023-2024 nei diversi settori delle montagne lombarde.
La stagione autunnale si rileva piuttosto ricca di precipitazioni solide con un conseguente deposito nevoso rilevante. Situazione che ha interessato la maggior parte delle montagne lombarde alle quote tra i 1800 m e i 2100 m in conseguenza a temperature superiori alla media stagionale. Infatti, si sono registrate temperature medie intorno a 7°C al di sopra dei 2000 m e climi ancora miti alle quote inferiori, come si evince dalla temperatura massima di 16°C registrata nella località di Madesimo Alpe Motta, stazione Campodolcino (1880 m) in data 29 ottobre 2022. Temperature che vedono un leggero abbassamento ai primi di novembre, così come nella seconda metà del mese, ove si registrano le prime modeste nevicate in quota con altezze di neve fresca al suolo a partire dai 15 cm.
Le perturbazioni di fine novembre e dicembre hanno principalmente interessato i settori più orientali della Lombardia, quali Retiche Orientali e Adamello, con livelli medi dei depositi nevosi di 30-40 cm, i quali costituiranno un importante contributo alle quote tra i 2100 m e i 2200 m. Per tutto dicembre e gennaio al di sopra dei 2300 m si possono annotare temperature oscillanti intorno alla media stagionale di circa -1°C e precipitazioni nevose abbastanza frequenti con conseguente incremento dell’altezza del manto nevoso. Novembre, dicembre e gennaio evidenziano apporti di moderata entità anche alle quote tra i 2400 m e i 2500 m, con singoli depositi di neve fresca fino a 50 cm (data 5 dicembre 2022) e successivo assestamento del manto nevoso intorno ai 120-130 cm per tutto l’inverno fino alla prima metà di aprile. In parallelo, per le località attorno ai 1800-1900 m, si sono registrati massimi di accumulo prettamente nel mese di dicembre, con apporti anche di 57 cm alla stazione di Madesimo (1880 m) in data 4 dicembre 2022. Tali eventi sono stati favoriti da temperature prossime agli 0°C con massime non superiori a 2°C.
In generale, il mese di febbraio si presenta piuttosto stabile con temperature sempre prossime ai 0°C oltre i 2000 m sui settori centro-orientali. Contesto favorevole alla preservazione del manto nevoso. A cavallo tra gennaio e febbraio si annotano venti prevalenti con velocità media di circa 8 m/s (equivalente circa a 30 km/h) in quasi tutte le stazioni di riferimento; la conseguenza da un punto di vista nivologico è la ridistribuzione del manto nevoso, con ampie zone erose alternate a locali accumuli anche di medio grandi dimensioni, e problematiche legate alla neve ventata (valanghe a lastroni).
Nella fascia alpina compresa tra i 1800 m e i 2000 m si registra a febbraio un periodo di 10 giorni particolarmente secchi e caldi per la media stagionale, con temperature di 9-10°C, con propensione alla parziale riduzione di spessore della neve depositata i mesi precedenti.
Marzo e aprile si rivelano mesi interessanti per le dinamiche di accumulo. Intorno ai 1800-1900 m si verificano importanti eventi nevosi con apporti di 20-30 cm su tutto l’arco delle Retiche lombarde in contemporanea a un abbassamento delle temperature minime, per le quali si registrano nella giornata del 15 marzo – 7°C a 2151 m Lanzada Palù e -14 °C a 3032 m al passo Marinelli. Alle quote superiori fino ai 2300 m i livelli di altezza neve si mantengono pressoché costanti intono ai 90 cm per l’intero periodo. Nonostante ciò, inizio aprile si presenta come un periodo di instabilità tra i 1800 m e i 2100 m dove si comincia ad avvertire un clima più primaverile, con le ultime leggere nevicate di pochi centimetri. Episodio rilevante si è verificato al 21 aprile deponendo al suolo ben 70 cm di neve fresca anche a 1900 m (zona omogenea delle Retiche Occidentali – area dell’alta Valchiavenna). Dato il periodo, tali apporti nevosi perderanno rapidamente spessore. La seconda metà di aprile si è prospettata proficua in termini di accumulo nevoso per le maggiori quote con eventi di precipitazione ancora di 20-30 cm nei pressi dei 2300 m e di 40-50 cm (14-21 aprile e 2 maggio) a 2400-2500 m. Nel suddetto periodo si sono registrate temperature massime intorno ai 10°C e picchi di temperature minime di -14°C. Tali cicli di fusione e rigelo hanno determinano un miglioramento complessivo della stabilità del manto nevoso.
Maggio è caratterizzato da temperature medie massime intorno ai 13°C e minime di 3°C (approssimati). Clima decisamente più mite anche a 2000 m con temperature medie di 10-11°C e a 3000 m di 5-6°C, decretando così il termine della stagione di accumulo nevoso.
Attività eolica poco rilevante in quanto inferiore a 5,5 m/s (ossia 20 km/h).
Sulle Prealpi lombarde, gli eventi nevosi sono stati più ricorrenti rispetto l’anno prima, ma di minor intensità. Infatti, il quantitativo di neve accumulata al suolo non supera i 20 cm tra i 1000 e i 1200 m e i 30 cm per le quote maggiori fino ai 1800 m. Inverno caratterizzato da un clima prettamente fresco e mai pienamente freddo, con oscillazioni termiche leggermente superiori alla media. A quote superiori i 1700 m, nelle sezioni delle Prealpi bresciane e lariane, si possono evidenziare tre importanti contributi alla componente nevosa stagionale rispettivamente a fine dicembre, fine gennaio e metà aprile. Eventi ritenuti rilevanti per il mantenimento di un sottile strato di neve al suolo, creatosi inseguito al miglior andamento stagionale che registra più giorni di nevicate, sebbene con quantitativi modesti. Mentre, nel settore bergamasco a quote inferiori ai 1100m, si calcolano volumi di neve ancora più contenuti.
Per tutte le località, con l’inizio di maggio si registrano trend negativi, con territorio privo di innevamento anche a quote superiori ai 1800m.
La stima del contenuto idrico della neve (SWE) a scala regionale, consente di valutare la quantità totale di equivalente in acqua immagazzinata nella neve e la sua distribuzione spaziale. Tale parametro riveste notevole importanza nel bilancio idrologico, in quanto rappresenta una riserva idrica che ha capacità di rilascio graduale ed è al tempo stesso un fattore da monitorare nella catena di controllo e di allertamento idrogeologico.
Il calcolo del SWE si basa sulla valutazione dell'estensione della copertura nevosa e sulla misurazione dell'altezza e della densità del manto nevoso.
I campionamenti sono stati svolti alle quote comprese tra i 2.877 metri sulla Vedretta di Savoretta ed i 3.645 del Ghiacciaio di Fellaria Orientale. Questi completano ed integrano i dati raccolti in continuo attraverso la rete capillare di stazioni nivometeorologiche automatiche presenti sul territorio montano lombardo collocate a quote inferiori.
Sono stati eseguiti decine di carotaggi e di misure dell’altezza del manto nivale su:
- ghiacciai del Vioz e Dosegù nel Sottogruppo Cevedale-San Matteo;
- ghiacciaio dei Vitelli nel Sottogruppo Ortles-Cristallo;
- ghiacciai dell’Adamello e del Pisgana nel Gruppo dell’Adamello;
- ghiacciai di Fellaria Orientale e dello Scalino nel Gruppo del Bernina.
- ghiacciai di Alpe Sud e di Savoretta nel Gruppo Sobretta-Gavia.
Rispetto agli anni precedenti non sono state effettuate le misure sul Fellaria Occidentale, ma sono stati campionati per la prima volta il ghiacciaio dello Scalino e di Savoretta.
Dai dati complessivamente raccolti si può confermare che l’ultima stagione sia stata caratterizzata da un innevamento nella media durante l’inverno e nettamente superiore nei mesi primaverili (considerando gli ultimi 15 anni) su tutte le montagne lombarde, rendendo la stagione 2023-2024 una delle migliori dell’ultimo ventennio come quantitativi di accumulo nivale.
Nell’immagine viene riportato l'equivalente in acqua della neve (SWE) calcolato a partire dai dati raccolti, espresso in kg/m² (ovvero considerato come il peso dell'acqua di disgelo per metro quadrato che risulterebbe se il manto nevoso si fondesse del tutto).
Sono stati riscontrati quantitativi di neve notevolmente superiori rispetto agli scorsi anni. Gli spessori variano tra i 2 e 7 m sui diversi ghiacciai, con minimo nelle quote più basse e una densità media di 560 kg/m3.
I valori più elevati di SWE sono stati misurati nella zona dell’alta Valmalenco sull’ apparato glaciale di di Fellaria Orientale (40 m di neve cumulata). Valori compresi tra 27 e 30 m di neve cumulata sui ghiacciai dello Scalino, dell’Adamello e Savoretta e tra i 20 e 24 m in Ortles-Cevedale e Sobretta con un incremento medio del 160% rispetto alla stagione 2022-2023.
Concludendo si può affermare che i primi mesi invernali della stagione 2023-2024 siano stati caratterizzati da accumuli nivali nella media. La primavera, ricca di perturbazioni, ha determinato significativi incrementi di spessore del manto a tutte le quote. Questi, favorendo la formazione di accumuli degni di nota sui ghiacciai posti alle fasce altimetriche superiori, oltre che rallentare il processo di fusione dei ghiacciai, migliorano il bilancio idrico della stagione in corso.
I ghiacciai rispondono in modo diretto e rapido alle dinamiche di cambiamento climatico (variazione temperature e regimi pluviometrici) modificando le proprie caratteristiche morfologiche e la loro dinamica con una riduzione della massa glaciale, un progressivo arretramento delle fronti glaciali, un incremento delle zone crepacciate, la formazione di depressioni e di laghi sulla superficie, l’aumento dell’instabilità di seracchi pensili. Questa grande sensibilità alle variazioni del clima rende i ghiacciai dei preziosi indicatori che consentono di quantificare l’intensità con cui sta agendo il riscaldamento globale.
Il Centro Nivometeorologico di ARPA Lombardia monitora diversi ghiacciai sull’arco alpino lombardo, sia mediante rilievi invernali, volti a quantificare l’entità degli accumuli nivali, che nel periodo estivo autunnale al fine di quantificarne la perdita di massa attraverso varie metodologie di rilievo (confronto letture paline ablatometriche, misure georadar, rilievi geodetici tramite GNSS e aerofotogrammetria).
In generale si può affermare che il 2024 è stato un anno relativamente negativo per il glacialismo alpino, considerando la forte riduzione di volume degli ultimi due anni. Infatti, il 2024 ha subito una riduzione glaciale molto inferiore rispetto al 2022 (anno peggiore della serie) e 2023. Anche se l'inverno e la primavera hanno registrato abbondanti precipitazioni, queste non sono state sufficienti a compensare l'impatto delle alte temperature estive, segnando in negativo il bilancio glaciologico lombardo con modeste perdite di massa. Fortunatamente le prime nevicate autunnali di fine settembre hanno bloccato questo trend negativo.
Nelle aree dei settori Retici sono state rilevate riduzioni di spessore medie di 1,8 metri a un'altitudine di 3000 metri, accompagnate da moderate variazioni negative delle fronti glaciali. Questi dati sottolineano la tendenza attuale, con una conseguente contrazione e arretramento delle lingue glaciali, ormai sempre più assottigliate e situate a quote progressivamente più elevate.
Questo quadro è coerente con quanto registrato a più larga scala sulle Alpi e a livello globale.
La stagione invernale 2023-2024 è stata caratterizzata da una criticità mediamente marcata.
Sui settori Retici, Adamello e Orobie il grado di pericolo maggiormente utilizzato (con una percentuale di circa il 45% dei bollettini emessi) è stato il 2 moderato (su una scala che va da 1 debole a 5 molto forte), mentre sui settori prealpini caratterizzati da maggior quota (Prealpi Lariane, Bergamasche e bresciane) il grado più ricorrente è stato l’1 debole.
Alle quote collinari delle Prealpi Varesine e Appennino Pavese, lunghi periodi dell’inverno sono stati caratterizzati da assenza di neve rispettivamente il 47% ed il 63% dei bollettini emessi (indicata sul bollettino con l’icona “no snow”).
Alle fasce altimetriche maggiori, il 3 marcato è stato emesso nel 40 % dei bollettini, con il grado 1 debole pari al 3%.
Il grado 4 forte è stato utilizzato in media 13 volte sui settori Retici, Adamello e Orobie e 10 volte nelle Prealpi Lariane di 10 volte. Nei settori delle Prealpi Brescine e Bergamasche è stato utilizzato 6 volte mentre per le Prealpi Varesine e gli Appennini Pavesini non vengono mai utilizzati.
Rispetto la passata stagione quella del 2023-2024 presenta una maggior criticità evidenziato da un maggior numero di giorni classificati con grado di pericolo 3 marcato e 4 forte.
La stagione invernale 2022/2023 è stata migliore rispetto all’inverno 2021-2022. La parte iniziale dell’inverno è stata caratterizzata da penuria di precipitazioni su tutti i settori lombardi, con un trend siccitoso analogo alla stagione 2021-2022. Gli spessori medi di innevamento registrati dalla rete di stazioni nivometeorologiche automatiche di ARPA Lombardia erano modesti a tutte le fasce altimetriche, lambendo il minimo storico. La primavera ha garantito una generale ripresa delle precipitazioni nevose, soprattutto alle quote medio-alte, favorendo un generale recupero dell’innevamento medio.
Dal confronto delle medie annuali per le rispettive stazioni di riferimento con i dati raccolti durante la suddetta stagione invernale, si può notare come il volume di neve fresca cumulata tendenzialmente sia al di sotto delle medie, salvo per la località di Aprica per la quale si rileva un leggero aumento. Pertanto, si conferma che le precipitazioni nevose sono state più abbondanti sulle montagne appartenenti al settore Orobico, con picchi nella sezione più a est. (vedi immagine)
Sebbene, l’innevamento sia stato favorito da temperature più attinenti alla media stagionale e da eventi di precipitazione in quota più regolari, il quantitativo di neve fresca al suolo continua a registrare un andamento in leggero calo rispetto alla media degli ultimi anni.
Di seguito vengono analizzati gli aspetti e gli eventi meteorologici principali che hanno caratterizzato la stagione invernale 2022-2023 nei diversi settori delle montagne lombarde.
L’inizio della stagione autunnale si rileva piuttosto asciutto con scarse precipitazioni solide e conseguente assenza di depositi nevosi rilevanti. Situazione che ha interessato la maggior parte delle montagne lombarde alle quote tra i 1800 m e i 2100 m in conseguenza a temperature superiori alla media stagionale. Infatti, si sono registrate temperature medie intorno a 7°C al di sopra dei 2000 m e climi ancora miti alle quote inferiori, come si evince dalla temperatura massima di 16°C registrata nella località di Madesimo Alpe Motta, stazione Campodolcino (1880 m) in data 29 ottobre 2022. Temperature che vedono un leggero abbassamento ai primi di novembre, così come nella seconda metà del mese, ove si registrano le prime modeste nevicate in quota con altezze di neve fresca al suolo a partire dai 15 cm.
Le perturbazioni di fine novembre e dicembre hanno principalmente interessato i settori più orientali della Lombardia, quali Retiche Orientali e Adamello, con livelli medi dei depositi nevosi di 30-40 cm, i quali costituiranno un importante contributo alle quote tra i 2100 m e i 2200 m. Per tutto dicembre e gennaio al di sopra dei 2300 m si possono annotare temperature oscillanti intorno alla media stagionale di circa -1°C e precipitazioni nevose abbastanza frequenti con conseguente incremento dell’altezza del manto nevoso. Novembre, dicembre e gennaio evidenziano apporti di moderata entità anche alle quote tra i 2400 m e i 2500 m, con singoli depositi di neve fresca fino a 50 cm (data 5 dicembre 2022) e successivo assestamento del manto nevoso intorno ai 120-130 cm per tutto l’inverno fino alla prima metà di aprile. In parallelo, per le località attorno ai 1800-1900 m, si sono registrati massimi di accumulo prettamente nel mese di dicembre, con apporti anche di 57 cm alla stazione di Madesimo (1880 m) in data 4 dicembre 2022. Tali eventi sono stati favoriti da temperature prossime agli 0°C con massime non superiori a 2°C.
In generale, il mese di febbraio si presenta piuttosto stabile con temperature sempre prossime ai 0°C oltre i 2000 m sui settori centro-orientali. Contesto favorevole alla preservazione del manto nevoso. A cavallo tra gennaio e febbraio si annotano venti prevalenti con velocità media di circa 8 m/s (equivalente circa a 30 km/h) in quasi tutte le stazioni di riferimento; la conseguenza da un punto di vista nivologico è la ridistribuzione del manto nevoso, con ampie zone erose alternate a locali accumuli anche di medio grandi dimensioni, e problematiche legate alla neve ventata (valanghe a lastroni).
Nella fascia alpina compresa tra i 1800 m e i 2000 m si registra a febbraio un periodo di 10 giorni particolarmente secchi e caldi per la media stagionale, con temperature di 9-10°C, con propensione alla parziale riduzione di spessore della neve depositata i mesi precedenti.
Marzo e aprile si rivelano mesi interessanti per le dinamiche di accumulo. Intorno ai 1800-1900 m si verificano importanti eventi nevosi con apporti di 20-30 cm su tutto l’arco delle Retiche lombarde in contemporanea a un abbassamento delle temperature minime, per le quali si registrano nella giornata del 15 marzo – 7°C a 2151 m Lanzada Palù e -14 °C a 3032 m al passo Marinelli. Alle quote superiori fino ai 2300 m i livelli di altezza neve si mantengono pressoché costanti intono ai 90 cm per l’intero periodo. Nonostante ciò, inizio aprile si presenta come un periodo di instabilità tra i 1800 m e i 2100 m dove si comincia ad avvertire un clima più primaverile, con le ultime leggere nevicate di pochi centimetri. Episodio rilevante si è verificato al 21 aprile deponendo al suolo ben 70 cm di neve fresca anche a 1900 m (zona omogenea delle Retiche Occidentali – area dell’alta Valchiavenna). Dato il periodo, tali apporti nevosi perderanno rapidamente spessore. La seconda metà di aprile si è prospettata proficua in termini di accumulo nevoso per le maggiori quote con eventi di precipitazione ancora di 20-30 cm nei pressi dei 2300 m e di 40-50 cm (14-21 aprile e 2 maggio) a 2400-2500 m. Nel suddetto periodo si sono registrate temperature massime intorno ai 10°C e picchi di temperature minime di -14°C. Tali cicli di fusione e rigelo hanno determinano un miglioramento complessivo della stabilità del manto nevoso.
Maggio è caratterizzato da temperature medie massime intorno ai 13°C e minime di 3°C (approssimati). Clima decisamente più mite anche a 2000 m con temperature medie di 10-11°C e a 3000 m di 5-6°C, decretando così il termine della stagione di accumulo nevoso.
Attività eolica poco rilevante in quanto inferiore a 5,5 m/s (ossia 20 km/h).
Sulle Prealpi lombarde, gli eventi nevosi sono stati più ricorrenti rispetto l’anno prima, ma di minor intensità. Infatti, il quantitativo di neve accumulata al suolo non supera i 20 cm tra i 1000 e i 1200 m e i 30 cm per le quote maggiori fino ai 1800 m. Inverno caratterizzato da un clima prettamente fresco e mai pienamente freddo, con oscillazioni termiche leggermente superiori alla media. A quote superiori i 1700 m, nelle sezioni delle Prealpi bresciane e lariane, si possono evidenziare tre importanti contributi alla componente nevosa stagionale rispettivamente a fine dicembre, fine gennaio e metà aprile. Eventi ritenuti rilevanti per il mantenimento di un sottile strato di neve al suolo, creatosi inseguito al miglior andamento stagionale che registra più giorni di nevicate, sebbene con quantitativi modesti. Mentre, nel settore bergamasco a quote inferiori ai 1100m, si calcolano volumi di neve ancora più contenuti.
Per tutte le località, con l’inizio di maggio si registrano trend negativi, con territorio privo di innevamento anche a quote superiori ai 1800m.
La stima del contenuto idrico della neve (SWE) a scala regionale, consente di valutare la quantità totale di equivalente in acqua immagazzinata nella neve e la sua distribuzione spaziale. Tale parametro riveste notevole importanza nel bilancio idrologico, in quanto rappresenta una riserva idrica che ha capacità di rilascio graduale ed è al tempo stesso un fattore da monitorare nella catena di controllo e di allertamento idrogeologico.
Il calcolo del SWE si basa sulla valutazione dell'estensione della copertura nevosa e sulla misurazione dell'altezza e della densità del manto nevoso.
I rilievi sono stati effettuati a quote elevate (oltre i 3000 m s.l.m.) ad integrare i dati raccolti in continuo attraverso la capillare rete di stazioni nivometeorologiche automatiche presenti sul territorio montano lombardo che però, attualmente, risultano collocate a quote inferiori.
Sono stati eseguiti decine di carotaggi e di misure dell’altezza del manto nivale su:
- ghiacciai del Vioz e Dosegù nel Sottogruppo Cevedale-San Matteo;
- ghiacciaio di Alpe Sud sul Monte Sobretta;
- ghiacciaio dei Vitelli nel Sottogruppo Ortles-Cristallo;
- ghiacciai dell’Adamello e del Pisgana nel Gruppo dell’Adamello;
- ghiacciai di Fellaria Orientale e Occidentale nel Gruppo del Bernina.
I campionamenti sono stati svolti alle quote comprese tra i 2.763 metri alla fronte del Ghiacciaio Pisgana ed i 3.620 del Ghiacciaio di Fellaria Orientale, nei pressi della Forcola di Bellavista.
Dai dati complessivamente raccolti si può confermare che l’ultima stagione sia stata caratterizzata da un innevamento migliore rispetto all’inverno precedente; condizione dovuta principalmente ai cospicui apporti nevosi primaverili che hanno interessato le quote maggiori.
Nell’immagine viene riportato l'equivalente in acqua della neve (SWE) calcolato a partire dai dati raccolti, espresso in kg/m² (ovvero considerato come il peso dell'acqua di disgelo per metro quadrato che risulterebbe se il manto nevoso si fondesse del tutto).
Nell’area dell’Adamello sono stati misurati mediamente 9 metri di neve cumulata, a differenza dei 3-4 metri della primavera 2022. Sui ghiacciai dell’alta Valtellina gli accumuli sono risultati variabili tra 8 e 11 metri di neve cumulata, con un incremento del 30-40 % in più rispetto allo scorso inverno. Anche nella zona dell’alta Valmalenco sono stati misurati valori superiori rispetto al 2022, con 17 metri di neve cumulata sull’altopiano del Fellaria Orientale e 9 metri di neve cumulata sul sottostante ghiacciaio del Fellaria Occidentale.
Considerando le caratteristiche fisico-meccaniche del manto nevoso, la qualità dell’innevamento è stata mediocre. A livello generale la stratigrafia è stata caratterizzata da una parte basale sgranata e porosa (riconducibile alla prima parte dell’inverno, ove le nevicate sono state sporadiche, alternate a periodi di freddo prolungato e venti persistenti), sopra le quali si sono deposte le nevicate primaverili, a tratti anche copiose e caratterizzate da densità ben più elevate. Questo livello superficiale ha preservato dalla fusione gli strati sottostanti sino ai primi di luglio. L’arrivo delle prime ondate di calore ha rapidamente ridotto gli spessori, dileguando in poco tempo l’intera coltre nivale.
I ghiacciai rispondono in modo diretto e rapido alle dinamiche di cambiamento climatico (variazione temperature e regimi pluviometrici) modificando le proprie caratteristiche morfologiche e la loro dinamica con una riduzione della massa glaciale, un progressivo arretramento delle fronti glaciali, un incremento delle zone crepacciate, la formazione di depressioni e di laghi sulla superficie, l’aumento dell’instabilità di seracchi pensili. Questa grande sensibilità alle variazioni del clima rende i ghiacciai dei preziosi indicatori che consentono di quantificare l’intensità con cui sta agendo il riscaldamento globale.
Il Centro Nivometeorologico di ARPA Lombardia monitora diversi ghiacciai sull’arco alpino lombardo, sia mediante rilievi invernali, volti a quantificare l’entità degli accumuli nivali, che nel periodo estivo autunnale al fine di quantificarne la perdita di massa attraverso varie metodologie di rilievo (confronto letture paline ablatometriche, misure georadar, rilievi geodetici tramite GNSS e aerofotogrammetria).
In generale si può affermare che il 2023 è stato un anno negativo per il glacialismo alpino, con valori di riduzione glaciale leggermente inferiori rispetto al 2022 (anno peggiore della serie). Anche quest’anno, l’effetto combinato di elevate temperature durante la stagione estiva, che si sono protratte anche all’inizio del periodo autunnale, e di precipitazioni invernali ridotte e al di sotto delle medie del periodo, hanno segnato in maniera evidente il bilancio glaciologico lombardo, che si mantiene negativo, con considerevoli perdite di massa.
Sui settori Retici sono state misurate riduzioni di spessore fino a 3 metri a 3000 m di quota, e variazioni frontali negative che evidenziano il trend in atto, con una conseguente contrazione e arretramento delle lingue, ormai sempre più smagrite e arroccate a quote progressivamente più elevate.
Questo quadro è coerente con quanto registrato a più larga scala sulle Alpi e a livello globale.
Una stagione di accumulo eccezionalmente secca e caratterizzata da temperature frequentemente superiori alla media.
Dai dati complessivamente raccolti si può confermare che l’ultima stagione sia stata caratterizzata da un innevamento notevolmente inferiore alla media su tutte le montagne lombarde; condizione dovuta principalmente alle scarse precipitazioni nevose verificatesi in quota: quasi totale assenza di precipitazioni nei mesi di gennaio e marzo 2022.
Unitamente agli scarsi apporti nevosi le temperature frequentemente superiori alla media hanno determinato un accumulo nivale e una derivante risorsa idrica vicini ai minimi registrati negli ultimi 15 anni (Figura 1 - Stima potenziale dell’equivalente idrico della neve (espresso in Milioni di metri cubi, Mmc), calcolata tramite spazializzazione delle stime puntuali e l’incrocio tematico con mappe di innevamento derivate da classificazione delle immagini satellitari, per il Bacino idrografico montano Adda-Mera-Lario).
Da gennaio lo spessore medio del manto nevoso è stato sotto la norma (Figura 2 - Andamento dello spessore di neve al suolo per diverse stazioni lombarde di riferimento durante la stagione invernale 2021-2022).
Di seguito vengono sintetizzati gli aspetti e gli eventi meteorologici principali che hanno caratterizzato la stagione invernale 2021-2022.
Tra ottobre e novembre 2021 si registrano quelli che si riveleranno poi essere i principali apporti nevosi della stagione. In particolare, la perturbazione del 5-6 ottobre porta, oltre i 1800m, accumuli nevosi tra i 15 e i 40 cm (massimi registrati oltre i 2500m di quota).
Il mese di novembre si presenta un mese ricco di apporti nevosi grazie al quale l’altezza di neve al suolo risulta in linea o superiore alla media del periodo. I principali apporti si registrano nelle giornate del 1° novembre, tra il 3-4 ed il 13-14 principalmente sui settori occidentali alpini e prealpini (oltre i 1800 m di quota) e tra il 25 e 28 novembre con un fenomeno non intenso quanto i precedenti ma continuativo su tutti i settori montani. Significativa durante quest’ultimo evento l’attività eolica che determina la formazione di diffusi lastroni soffici da vento.
Il mese di dicembre, ad esclusione della nevicata dell’8/12, si presenta come un mese eccezionalmente “secco” con apporti nevosi sotto la media del periodo e caratterizzato, a partire dal 11/12, da episodi e condizioni di foehn e temperature miti. Nell’ultima settimana di dicembre il principale problema valanghivo risulta difatti essere legato a valanghe di neve umida e bagnata già al di sotto dei 2200 m di quota.
Anche il mese di gennaio 2022 si caratterizza per anomalie di precipitazioni negative su tutto il territorio regionale (unico evento di debole intensità registrato il giorno 5) e temperature medie, ad esclusione di 2-3 singoli casi, per tutto il mese oltre la norma. Ne consegue che i quantitativi di equivalente idrico della neve stimati nei bacini montani risultano complessivamente inferiori alla media mensile.
Durante la prima metà di febbraio si registrano diverse precipitazioni nevose, per lo più accompagnate o immediatamente seguite da attività eolica con la conseguente formazione di nuovi accumuli e lastroni da vento. La neve fresca accumulata nel mese di febbraio si aggira mediamente tra i 30 e i 40 cm. Nonostante tali apporti l’altezza neve al suolo risulta sotto la media e vicina ai minimi del periodo di riferimento.
Il mese di marzo si presenta come un altro mese eccezionalmente secco con assenza di significativi apporti nevosi e temperature medie generalmente sopra la media in particolare per le quote più elevate (es. Stazione di Livigno – La Vallaccia 2660 m s.l.m.). L’altezza di neve al suolo è su tutto il territorio lombardo complessivamente prossima ai minimi storici.
Aprile si afferma come un mese dinamico e spiccatamente primaverile, caratterizzato dall'alternanza tra le prime avvezioni miti da sud e incursioni fresche piovose. Nuovi moderati apporti nevosi a inizio mese si depositano su un manto di neve vecchia per lo più consolidato; sulle Orobie in particolare caratterizzato dalla presenza di croste da fusione e rigelo. Aumento del grado di pericolo valanghe in seguito all’evento del 23-24 aprile dettato dalla presenza di nuovi accumuli di neve ventata.
Al “clima fresco” del mese di aprile segue un mese di maggio caratterizzato, già a inizio della seconda decade, da temperature diurne decisamente superiori alla media ed da un clima pienamente “estivo” (importante anomalia su tutto il territorio regionale ancora più marcata in quota). La situazione d’innevamento sulle Alpi, che già si presentava estremamente deficitaria per via delle scarse precipitazioni dei mesi precedenti, con le temperature elevate, fa sì che già dalla prima metà del mese di maggio si estingua la poca neve ancora presente sotto i 2400m di quota.
Per maggiori dettagli ed approfondimenti consultare lo Speciale della Rivista Neve e Valanghe (AINEVA) dedicato ai Resoconti Stagionali: AINEVA - Resoconti Stagionali
Per saperne di più
Data ultimo aggiornamento: 27/10/2023
Data ultimo aggiornamento
27/10/2023
Data inserimento: 01/03/2023
Data inserimento
01/03/2023
Struttura responsabile del contenuto informativo: Neve e ghiacciai
Struttura responsabile del contenuto informativo
Neve e ghiacciai
Struttura responsabile della pubblicazione: Comunicazione
Struttura responsabile della pubblicazione
Comunicazione
Per saperne di più