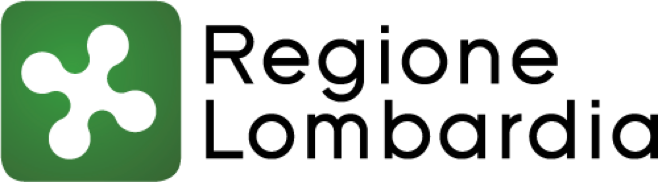Termovalorizzatori
In Lombardia sono presenti 12 termovalorizzatori di rifiuti urbani che nel corso del 2022 hanno trattato 2.269.527 tonnellate di rifiuti.
Del totale valorizzato energeticamente 1.018.550 tonnellate sono costituite da rifiuti urbani, 451.761 tonnellate dalla frazione secca derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti, 406.406 tonnellate da CDR, 28.525 tonnellate da rifiuti sanitari e 366.175 tonnellate da altri rifiuti speciali.
Gli impianti hanno recuperato energia elettrica per un valore pari a 1.712.476 MWh nel 2022, mentre il recupero termico è stato pari a 1.758.872 MWh; nel complesso, un quantitativo di energia capace di soddisfare il fabbisogno medio annuo di:
- circa 1,29 milioni di famiglie corrispondente con il 28% delle famiglie lombarde (dato ISTAT 2022). considerando un consumo medio di 2.700 kWh (fonte ARERA) per una famiglia composta da 4 persone;
- circa 1,58 milioni di famiglie corrispondenti con il 35% delle famiglie lombarde (dato ISTAT 2022) considerando un consumo medio di 2.200 kWh (fonte ARERA) per una famiglia composta da 2 persone.
Secondo i dati ISTAT 2022 in Lombardia il numero medio dei componenti per famiglia è pari a 2,2 persone.
L’acquisizione mensile dei dati dei rifiuti valorizzati termicamente dagli impianti regionali, consente di monitorare costantemente tipi e quantità dei rifiuti gestiti. L'immagine in calce fotografa i dati del 2022.
Ci sono, inoltre, altri 58 impianti di incenerimento e co-incenerimento che nel 2022 hanno trattato altre 675.689 tonnellate di rifiuti.
PER SAPERNE DI PIU'
Data ultimo aggiornamento: 13/02/2024
Data ultimo aggiornamento
13/02/2024
PER SAPERNE DI PIU'